|
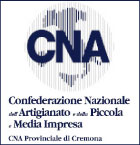
|
|
| Welfare Italia |
| Foto Gallery |
| Ultima immagine dal Foto Gallery di Welfare Italia |

|
|
 |
| Ultimi Links |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Etica - Criteri condivisi e condivisibili (di Luigi Manconi) |
 |
|
15.12.2006
 Su alcune controversie politico-morali Su alcune controversie politico-morali
Le questioni che qui tratterò hanno, ognuna, uno spessore etico-
giuridico assai robusto; e implicazioni particolarmente delicate e
talvolta aggrovigliate. E, tuttavia, questo non impedisce che siano
trattate sul piano del dibattito pubblico e della decisione politica,
a partire da due criteri essenziali e condivisi (meglio:
condivisibili).
Il primo criterio teorico-pratico è quello della «riduzione del
danno»: ovvero la traduzione in termini politico-sociali di quel
principio che, nella teologia e nella morale del cattolicesimo, è
il «male minore». Il secondo criterio risiede nella consapevolezza
della possibilità di fondare e argomentare in termini etici - non
necessariamente di ispirazione religiosa - le opzioni su quei temi
controversi e la loro trascrizione normativa.
Questo può aiutare a trovare soluzioni comuni su alcune questioni
aperte.
1) Il confine tra cura doverosa e accanimento terapeutico è sottile,
lo sappiamo: e spesso incerto.
Ma quando una terapia si rivela
inequivocabilmente incapace di fermare il progredire devastante del
male, di alleviare le sofferenze e di migliorare in qualche misura la
qualità di vita del paziente, lì si ha accanimento terapeutico.
E, in presenza di una terapia ostinata e inutile, il codice
deontologico dei medici, tutta la giurisprudenza e i protocolli
scientifici sono chiari: quella terapia va sospesa. Come affermò
l'allora cardinale Joseph Ratzinger, all'epoca Prefetto della
Congregazione per la Dottrina della Fede, «la rinuncia
all'accanimento terapeutico è anche moralmente legittima».
La vicenda di Piergiorgio Welby rientra in quella definizione? A mio
avviso, sì. Senza quella macchina, senza il ventilatore polmonare, la
sua vita si sarebbe conclusa da tempo e, come dire?, naturalmente.
L'intervento del ventilatore si presenta, pertanto, come una protesi,
un sussidio meccanico, una strumentazione tecnologica, destinata a
prolungare artificialmente la vita di Welby. Questo intervento -
utile, e fin provvidenziale, come soluzione d'urgenza e terapia
d'emergenza - in una situazione di cronicizzazione, si riduce a
motivo di coercizione e afflizione e a fonte di sofferenze.
Interrompere l'attività di quella macchina significa sospendere una
terapia fattasi aggressiva e ostile.
Non c'è nulla di utilitaristico in questo ragionamento e non c'è
alcuna svalutazione del significato della vita umana. Certo, quella
vita può avere un senso e una qualità anche quando non risponde ai
parametri economicistici, salutistici e "mondani" della mentalitÃ
corrente: ma un corpo che decade progressivamente a sede esclusiva di
sofferenze rischia di negare qualunque senso alla sopravvivenza,
riducendola a mera perpetuazione del dolore.
Sospendere quel trattamento sanitario è, dunque, ragionevole,
pietoso, perfettamente coerente con la nostra Costituzione e, poi,
con leggi, regolamenti e codici professionali: e risponde a
un'istanza morale, facendosi carico della sofferenza del malato
terminale, e delle «scelte tragiche» che quella sofferenza impone.
2) Le tabelle relative alle sostanze stupefacenti sono una questione
esclusivamente di natura giuridica, medica, penale e sociale. Di
conseguenza, con criteri giuridici, medici, penali e sociali vanno
elaborate e valutate. Non certo in base a opzioni morali o religiose.
Tali opzioni sono importanti e contano, ma vanno fatte valere altrove
e altrimenti rispetto agli ambiti e ai parametri che devono orientare
la fissazione di quei limiti tabellari.
Tali limiti, all'interno della normativa vigente, hanno la sola
funzione (approssimativa e imperfetta) di indicare un qualche
accettabile confine tra detenzione a fini di uso personale e
detenzione a fini di spaccio. A questo, e solo a questo, sono
funzionali quei limiti.
Fissare quelle soglie massime risponde esclusivamente a un'esigenza
di efficacia. Ovvero evitare il carcere, e ciò che comporta, a chi
non è spacciatore: così come dichiara di volere la legislazione
vigente (Fini-Giovanardi compresa).
Le scelte morali si collocano altrove, e sono legittime e preziose,
ma non devono interferire con quei limiti tabellari. Fissare,
poniamo, a 5 o a 10 quel tetto non significa disapprovare (se il
limite è a 5) o approvare (se è a 10) il consumo di sostanze.
Significa permettere che un certo numero di consumatori (se il limite
è più alto) o un numero ancora superiore (se il limite è più basso)
entri in carcere - contro la ratio della stessa legge, che pure
contestiamo.
Dopo di che, superato o ridotto ai minimi termini il rischio
detentivo per i consumatori di sostanze, si porrà il problema di
elaborare intelligenti e razionali politiche di dissuasione dal
consumo: tanto più efficaci quanto più saranno dirette,
contemporaneamente, nei confronti delle cosiddette droghe legali
(alcol e tabacco). A questo punto, ciascuno farà valere le proprie
opzioni morali, le proprie strategie educative, la propria
ispirazione anche religiosa.
3) A proposito di coppie di fatto, il punto cruciale mi sembra il
seguente: alla famiglia eterosessuale fondata sul matrimonio si
riconosce un progetto, una condivisione di aspettative e di valori e,
dunque, una costituzione morale. Cosa, quest'ultima, che si nega alle
altre forme di convivenza e che colloca queste, pertanto, in una
condizione di inferiorità : innanzitutto morale. E infatti, secondo i
sostenitori in buona fede dell'unicità della famiglia tradizionale,
le «altre famiglie» possono essere tollerate e, in alcuni casi e per
certe prerogative, tutelate: senza riconoscere loro, però, la piena
dignità di relazione, dotata di una intenzionalità morale e di un
progetto antropologico-sociale. E, ancor prima, senza riconoscerle
come famiglie (e, addirittura, senza dirle famiglie). Questo sia nel
caso delle famiglie di fatto a composizione eterosessuale, sia nel
caso delle unioni omosessuali. Tanto la prima tipologia quanto la
seconda vengono considerate come espressione, se non di disordine, di
irregolarità (sociale e morale): e, dunque, suscettibili - al più -
di venire tollerate (perché diventate fenomeno statisticamente
rilevante).
Ma questo non è sufficiente. Non lo è, in primo luogo, rispetto alle
trasformazioni avvenute (e da decenni!) nella società italiana;
trasformazioni culturali e sociali, che hanno determinato il
passaggio da una tipologia di famiglia a una pluralità di forme
relazionali e coniugali. Così che - oggi, in Italia - le «nuove
famiglie» riguardano milioni di persone e costituiscono il 17% di
tutte le aggregazioni familiari.
Ma la tolleranza risulta insufficiente per una seconda (ancora più
importante) ragione: perché non tiene conto della
grande «trasformazione morale» in atto. Ed è il punto che più mi
preme sottolineare.
Quella trasformazione consiste, sostanzialmente, in questo: una gran
parte delle famiglie di fatto (eterosessuali e omosessuali) fonda la
propria scelta relazionale e coniugale su principi morali. Che non
sono, certo, quelli della «morale di maggioranza» (di derivazione
religioso-cattolica): ma che, comunque, chiedono riconoscimento e
domandano tutela.
A ben vedere, poi, in termini giuridici, i Pacs si limitano a
prevedere l'allargamento del numero di cittadini garantiti da alcuni
diritti: che sono una parte di quelli attualmente riconosciuti a due
persone che contraggono matrimonio. Chi promuove una visione
esclusivizzante di quei diritti («Vuoi usufruirne? sposati!»)
fraintende la sostanza stessa delle libertà cui essi sono preposti.
Quella sostanza è positiva e tende a essere universale e generale. Se
è vero che l'esercizio di un diritto non può condurre alla violazione
di un altro diritto (da qui il principio della «coesistenza dei
diritti»), è altresì vero che - come scrive Giuseppe Capograssi - i
diritti «sono tra di loro solidali, fanno insieme sistema; nessuno
può essere sacrificato col pretesto di arrivare, mediante questo
sacrificio, all'appagamento degli altri». Ecco, esemplarmente, un
caso in cui si rispettano entrambe le condizioni: riconoscere diritti
ai cittadini impegnati in una convivenza duratura e solidale non
minaccia i diritti di alcun altro. Per contro, riconoscere quei
diritti vuol dire promuovere quel principio di mutualità , fare
sistema, ridurre le disparità , garantire tutela e possibilità di
convivenza: oltre che tra due persone, tra i cittadini tutti.
Rifiutare ciò è, a mio avviso, un errore grave: significa ignorare
domande e comportamenti assai diffusi e significa accogliere una
visione della società italiana, propria di alcuni settori più
malinconicamente conservatori delle gerarchie ecclesiastiche: ovvero
la società italiana come un deserto etico, dove resiste - assediata e
clamans - la morale cattolica, quale solo presidio di valori forti.
Le cose non stanno affatto così. La crisi della «morale di
maggioranza» (che fu di maggioranza) non ha causato un vuoto di
valori e di principi - il deserto dell'etica, appunto - ma ha
prodotto, al contrario, un pieno di morali. Al plurale: morali di
gruppo e di comunità , di subcultura e di tendenza, di minoranze e di
identità . E tuttavia morali. Parziali e provvisorie, ma qualificanti
e dirimenti per coloro che vi si riconoscono e meritevoli di rispetto
e di tutela in una società pluralista.
Welfare Italia
Hits: 1926
Cronaca >> |
|
|
 |
|
|
 |
|
I commenti degli utenti (Solo gli iscritti possono inserire commenti)
|
 |
|
|
|
|
 |
|
