|
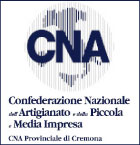
|
|
| Welfare Italia |
| Foto Gallery |
| Ultima immagine dal Foto Gallery di Welfare Italia |

|
|
 |
| Ultimi Links |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
| La tragedia della memoria rovesciata |
 |
|
9.04.2007
 Andrea casalegno, giornalista de La Stampa, scrive al suo direttore (www.lastampa.it - 6 aprile 2007) Andrea casalegno, giornalista de La Stampa, scrive al suo direttore (www.lastampa.it - 6 aprile 2007)
Di seguito, la risposta del direttore de La Stampa ed anche quella di Piero Fassino
Terrorismo, la tragedia della memoria rovesciata
di Andrea Casalegno
Caro direttore, ti scrivo, cosa insolita per un tuo giornalista,
perché abitualmente mi occupo di temi culturali mentre questa volta
sono in gioco da un lato valori umani fondamentali, dall'altro la
ricostruzione del nostro recente passato. A trent'anni di distanza si
infittiscono le rievocazioni degli "anni di piombo". Ben venga una
riflessione ponderata su quegli eventi sanguinosi, meglio ancora se
sostenuta da nuovi elementi di fatto.
Ma esibire buoni sentimenti con trent'anni di ritardo, capovolgendo
il giudizio sulle dolorose decisioni di allora, è da irresponsabili.
Ha cominciato l'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga,
ministro dell'Interno nel 1977-78, dichiarando al «Corriere della
Sera» che oggi non invierebbe più i mezzi blindati della polizia
contro «il movimento del '77»: un ripensamento che oggi non costa
nulla e nella sua futilità suona offensivo per le vittime. Poi, il
segretario politico dei Ds Piero Fassino e l'ex direttore dell'UnitÃ
ed ex presidente della Camera dei deputati Pietro Ingrao hanno
dichiarato che nel 1978 è stato «un errore» non trattare con le
Brigate rosse per salvare la vita del presidente della Democrazia
cristiana Aldo Moro.
A quel tempo, come dirigenti del Partito comunista, condividevano
pienamente la «linea della fermezza »; oggi la ritengono sbagliata
perché «è sempre giusto salvare una vita». E qualcuno ha addirittura
messo sullo stesso piano lo scambio di prigionieri che ha salvato la
vita a Mastrogiacomo, il giornalista di Repubblica sequestrato in
Afghanistan, con la liberazione dei brigatisti chiesta nel 1978 dai
terroristi che tenevano prigioniero Aldo Moro. Questi ripensamenti
tardivi suggeriscono una ricostruzione dei fatti che può trarre in
inganno i nostri giovani lettori. Qualcuno ha addirittura presentato
i politici contrari alla trattativa come i «veri assassini» di Moro.
Nel suo libro sul '77 Lucia Annunziata parla di «parricidio» a
proposito dei dirigenti democristiani e del loro presidente. In
simili ricostruzioni è implicito che sarebbe bastato un gesto di
umanità per salvare la vita di Moro. Si è proclamato addirittura,
come se fosse un fatto scontato, che «eravamo in guerra e in guerra è
previsto lo scambio di prigionieri». Tutto falso. Non basta
dichiarare guerra perché la guerra esista. Non ci fu alcuna guerra,
ma lo scontro sanguinoso fra il nostro Stato democratico e una banda
di assassini autoproclamatasi «avanguardia rivoluzionaria ». I
ferimenti, gli omicidi, per quanto numerosi e dolorosi,non hanno mai
avuto alcun rapporto con un'autentica attività rivoluzionaria in
grado di cambiare l'assetto politico e sociale del Paese. Essere
riconosciuti come «combattenti» era proprio l'obiettivo fondamentale
delle Brigate rosse.
La «fermezza» non fu un patto scellerato fra Dc e Pci ma una linea di
condotta condivisa dall'intero schieramento politico, compresi molti
dirigenti socialisti, come Sandro Pertini e Leo Valiani. Chi pensa,
oggi, che allora si potesse, si dovesse cedere ha dimenticato i
cinque agenti di scorta assassinati in via Fani. Le lettere di Moro,
autentiche per chiunque sapesse intendere, chiedevano di trattare. Lo
chiedeva la sua famiglia. Respingere quella richiesta di aiuto non
deve essere stato facile né per Cossiga, né per il segretario della
Dc Benigno Zaccagnini, né per il pontefice Paolo VI, che chiese
agli «uomini delle Brigate rosse» di lasciare libero Moro «senza
condizioni». Tutti e tre erano amici personali di Aldo Moro. Con che
disinvoltura, oggi, si "corregge" il loro errore e li si accusa di
mancanza di umanità !
Problema diverso sono le connivenze che protessero e forse pilotarono
le Br dall'interno degli apparati deviati dello Stato. Il fatto che
l'unità di crisi presso il ministero dell'Interno fosse quasi
interamente costituita da iscritti alla loggia massonica P2 vorrà pur
dire qualcosa. Ã probabile che le indagini siano state sviate da
quelle complicità , neutralizzando l'unica via per salvare la vita di
Moro: individuare la sua prigione. Ma di queste coperture i capi
brigatisti, Mario Moretti in testa, non hanno mai parlato.
***
La risposta del Direttore de La Stampa
Caro Andrea, questa insolita corrispondenza pubblica tra colleghi
necessita, soprattutto a beneficio dei lettori più giovani, di una
spiegazione. Noi ci conoscemmo, caro Andrea,nella più drammatica
delle occasioni: trent'anni fa, sulla porta di una stanza
dell'ospedale Molinette di Torino, nella quale tuo padre Carlo,
colpito dal terrorismo rosso, lottava invano contro la morte. Io non
dimenticherò mai la dolcezza della tua espressione di dolore e
l'infinita cortesia riservata a un cronista invadente. So quanto ti è
costato scrivere questa lettera. Ma il sacrificio, credimi, non sarÃ
inutile. Spero che la leggano con attenzione coloro che, con
superficialità e improvvisi vuoti di memoria, sono approdati al
proscenio dei "ripensamenti tardivi", al gioco intellettuale
dei "se", ai gesti umanitari retrospettivi tanto belli da esibire
quanto privi di costi. Le rievocazioni degli " anni di piombo"si
susseguono mentre gran parte delle vittime di quella stagione del
terrorismo (non ci fu alcuna guerra),battuta solo dalla fermezza e
dalla dignità dello Stato, giace in uno scandaloso dimenticatoio. La
scena pubblica vede, al contrario, molti dei colpevoli scrivere libri
e dare interviste. La memoria si è rovesciata.
***
La Stampa, 8 aprile 2007
Fassino: il diritto di cambiare idea
Il segretario Ds Piero Fassino risponde ad Andrea Casalegno, che in
una lettera a Il Sole 24 ore, ripresa da La Stampa, ha denunciato
la «memoria rovesciata» sulla «linea della fermezza» adottata in
occasione del caso Moro.
PIERO FASSINO *
Caro Andrea,
ho vissuto - come te - a Torino la stagione buia del terrorismo.
E so
bene quanto terribili siano stati quegli anni. Anni nei quali ogni
mattina - tra le 5 e le 6, quando gli operai del primo turno entrano
in fabbrica - il mio telefono squillava e dall'altro capo del filo
c'era qualche nostro compagno che mi avvisava sconvolto che un
caporeparto era stato appena ucciso o un caposquadra gambizzato o
l'auto di un sindacalista bruciata. Anni nei quali poliziotti,
carabinieri, agenti penitenziari venivano freddati con spietatezza
solo per la divisa che portavano. Anni nei quali i muri di Torino
erano invasi dalla stella a 5 punte delle Br, accompagnata spesso da
minacce di morte (come «Fassino ti spareremo in bocca»). E ricordo
bene quando le Br assassinarono tuo padre: lo sgomento della città e
la sensazione di impotenza che ci attanagliò, accresciuta
dall'insuccesso dello sciopero di protesta. E traemmo proprio da
quell'assassinio così vigliacco la forza e la determinazione per
contrastare definitivamente ogni lettura indulgente, riduttiva o
giustificazionista, mettendo in campo una risposta democratica forte
che sconfiggesse le Br e la loro criminale eversione.
Scrivo tutto questo per fugare in te, e in chi abbia seguito il
dibattito di queste settimane sul caso Moro, l'idea che vi sia in me
scarsa memoria o sottovalutazione di quel che accadde trent'anni fa.
Non è così. Il terrorismo fu una minaccia esiziale per la democrazia
e fu giustissimo combatterlo con la massima determinazione e
intransigenza. E io condivisi la linea della «fermezza» e non ne
declino certamente oggi la responsabilità . Ciò non impedisce di
chiedermi, trent'anni dopo, se la linea della fermezza dovesse
comportare necessariamente l'estremo sacrificio della vita di Aldo
Moro. Non sono convinto, ad esempio, che un'eventuale trattativa per
ottenere la liberazione del leader Dc avrebbe avuto come inevitabile
conseguenza una resa al terrorismo, contro il quale credo si sarebbe
continuato a combattere con la stessa intransigenza.
Né sono convinto che salvare la vita di Moro avrebbe voluto
dire «riconoscere» le Br, sulle quali il nostro drastico giudizio non
sarebbe certo cambiato. E mi chiedo anche se la crisi della
Repubblica, che da quell'assassinio in poi divenne via via più acuta
e inarrestabile, sarebbe stata la stessa con Moro vivo. Mi si può
obiettare che in realtà non c'erano margini, perché alle Br - per
dimostrare la loro invincibile potenza - serviva assai di più
uccidere Moro che qualsiasi trattativa. Anche questa è una tesi che
certo va considerata nel riflettere su quel periodo così drammatico.
Insomma: domande e riflessioni che non credo illegittime e su cui
naturalmente è del tutto lecito avere opinioni diverse. Quel che mi
pare meno legittimo è bollare le opinioni da te non condivise
come «irresponsabili», «futilità », «esibizione tardiva di buoni
sentimenti». Comprendo la sofferenza atroce che ogni riflessione su
quegli anni suscita in te, così colpito personalmente dalla brutalitÃ
assassina delle Br. Ma ti prego di credere che chi oggi continua a
riflettere su quegli anni non lo fa per esibizionismo, ma perché
quella pagina drammatica ha segnato la vita di tutti noi e del Paese.
Con amicizia.
*Segretario dei Democratici di sinistra
|
|
|
 |
|
|
 |
|
I commenti degli utenti (Solo gli iscritti possono inserire commenti)
|
 |
|
|
|
|
 |
|
