|
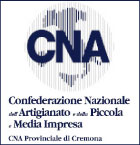
|
|
| Welfare Italia |
| Foto Gallery |
| Ultima immagine dal Foto Gallery di Welfare Italia |

|
|
 |
| Ultimi Links |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Nuovi cinquantenni e secondi cinquantanni |
 |
|
15.05.2007
 Luciano Abburrà Elisabetta Donati Luciano Abburrà Elisabetta Donati
NUOVI CINQUANTENNI E SECONDI CINQUANTANNI
Due ricerche su donne e uomini adulti in transizione
verso nuove etÃ
L’allungamento delle speranze di vita non riguarda solo i comportamenti delle persone anziane -
anche se di per sé rappresenta già una bella variazione per coloro che a 65 anni hanno un’attesa
di vita media tra i 15 anni (gli uomini) e i 20 anni (le donne). Ma il mutamento modifica la
collocazione temporale, i contenuti e la durata di tutte le età , consegnando a tutti nuove
opportunità e responsabilità verso gli impegni del presente e del futuro.
Le coorti di età comprese fra i 50 e i 60 anni sono collocate in una posizione di avamposto
rispetto ai processi che impegnano le nostre società a comprendere e sperimentare le
conseguenze dei cambiamenti nella struttura per età della popolazione: le raccomandazioni
dell’Unione europea li descrivono come una componente strategica della popolazione, da cui ci
si aspetta che investa ancora per qualificarsi a beneficio dello sviluppo economico, e nello stesso
tempo sia responsabile della cura e dell’assistenza dei giovani (almeno fino ai 35 anni) e degli
anziani (gli over 75), oltre a saper operare attivamente per la promozione del proprio benessere
individuale e collettivo. In effetti, il cambiamento dell’ageing muta non solo la distribuzione per
età , ma anche i contenuti delle esperienze e delle aspettative di ruolo di ciascun gruppo di
popolazione: se fra gli over 65 solo la metà si definiscono anziani, e fra i trentenni solo la metÃ
si definiscono adulti, che dire di chi appartiene alla fascia di età compresa fra i 50 e i 60 anni?
Queste persone in età adulta – che devono in parte sostituire i giovani “mancanti” nei posti di
lavoro, alimentando i processi di innovazione in corso, e al contempo devono prendersi cura dei
più anziani, che aumentano e vivono più a lungo – sono quelle su cui oggi si cumula il maggior
numero di domande di cambiamento, e sono anche quelle che possono contare sul minor
numero di aiuti esterni nel trovare le risposte. I loro comportamenti e stili di vita paiono
rappresentare una sorta di laboratorio privilegiato da cui attendersi indicazioni e proposte per
ridisegnare nuovi assetti della connessione sociale, più in linea con le nuove articolazioni di una
ageing society.
Ma loro, come si percepiscono?
Il programma di ricerca intrapreso dall’IRES Piemonte sui “nuovi cinquantenni” si propone di
offrire elementi conoscitivi sulle esperienze di vita, le risorse, le esigenze di un segmento
rilevante e crescente della popolazione adulta, contribuendo a promuovere nuovi orientamenti
sui processi di transizione nell’età adulta - dei quali il passaggio al pensionamento è certamente
un riferimento reale e simbolico importante, per le diverse transizioni implicate nelle
interdipendenze fra salute, lavoro, guadagno, interessi personali e responsabilità familiari.
L’attività di ricerca complessiva ha compreso due distinte fasi di lavoro empirico:
un’attività di ricognizione e di studio di carattere esplorativo, basata su alcuni casi aziendali
approfonditi soprattutto con metodi qualititativi: focus groups ed interviste a lavoratori maturi e
pensionati recenti;
un’indagine empirica su un campione statisticamente rappresentativo della
popolazione regionale di 50-60 anni, per cogliere e misurare le tendenze in atto su una scala
più ampia, con l’uso di uno strumento standardizzato: una survey con questionario ad un
campione di 1000 persone.
Sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti con le due indagini, di chi stiamo parlando
quando diciamo cinquantenni oggi?
Sulla base dei risultati, si può dire in primo luogo che i cinquantenni sono donne e uomini
coniugati, che vivono in famiglie lunghe e strette dove il nido non è ancora vuoto: sotto
lo stesso tetto abitano i figli, sotto tetti diversi ma non lontani abitano i genitori, tuttora viventi
in quasi il 60% dei casi, e poco più in là i nipoti, che però sono pochi. Quindi, i cinquantenni
sono mamme e papà di uomini e donne che, avendo mediamente meno di trentanni, sono
giovani. Allo stesso tempo sono essi stessi ancora figli e figlie di genitori anziani, di cui si
prendono cura in relazione alle specifiche esigenze e modalità dei rapporti che li caratterizzano.
La loro centralità nella rete delle relazioni familiari è sostenuta e legittimata dalla loro
centralità anche nella produzione economica del reddito: sono per 2/3 persone ancora
occupate e lavorano quasi totalmente a tempo pieno, con un lavoro dipendente come operai,
impiegati ed insegnanti per lo più, una quota più limitata in modo autonomo, pochi come quadri
o dirigenti. Prevedibilmente, tra i 50-54enni gli occupati sono molto più frequenti (86%) che fra
i 55-60enni. Fra questi ultimi molte storie lavorative ad inizio precoce, per l’agire combinato di
anzianità contributive e incentivi aziendali, hanno già avuto esito nel pensionamento (53%).
Comunque, anche fra i più maturi, quasi la metà lavora, anche se quasi un occupato su tre
avrebbe già i requisiti per la quiescenza.
Tra tutti gli occupati due su tre dicono che una ragione “molto importante”, per continuare a
lavorare è raggiungere i requisiti necessari per andare in pensione: nei fatti, l’80% degli
intervistati non ha ancora maturato la contribuzione sufficiente, con differenze che vanno
dall’85% dei 50-54enni al 68% dei 55-60enni. Tuttavia, questa non è l’unica ragione. In
percentuali che oscillano intorno al 50% dicono che sono “molto importanti” sia l’obiettivo di
migliorare il loro livello di reddito sia il fatto che a loro il lavoro piace, mentre assume una
particolare accentuazione fra i 55-60enni l’obiettivo di “mantenersi attivi”.
Tra donne e uomini le differenze più significative sono di accento, più che di tono, anche se non
vanno sempre nella direzione attesa: per esempio, fra le ragioni per cui lavorano ancora,
all’obiettivo di migliorare il reddito viene attribuita molta importanza più dalle donne (64%), così
come accade alla valutazione che il lavoro piace e al desiderio di mantenersi attivi (entrambi
51%).
Dunque, il lavoro è una necessità ma è anche fonte di soddisfazione per molti e molte:
degli occupati, circa uno su tre si dice “molto soddisfatto” del lavoro attuale, circa il doppio di
quanti si dicono “poco o per nulla soddisfatti” (17%). I cinquantenni, insomma, partecipano e
sono tra i protagonisti di quel processo di trasformazione del lavoro che ne ha progressivamente
migliorato la qualità , diminuita la fatica, a fronte di un aumento dello stress e delle responsabilità .
Certo, ne ha accresciuta anche l’incertezza. Ma questa è, almeno secondo gli intervistati, che
sono donne e uomini occupati o pensionati, più nell’orizzonte esistenziale dei più giovani, dei
loro figli e delle loro figlie o dei colleghi assunti temporaneamente e con cui spesso faticano ad
entrare in relazione.
Loro, invece, sono nell’occhio del ciclone della riforma delle pensioni, quella che fino ad ora è
stata presentata agli italiani come una incresciosa operazione di risanamento dei conti, sganciata
da ogni altro ordine di ragionamento che riguardi le nuove opportunità esistenziali, insieme ai
nuovi rischi sociali, legati ai mutamenti del corso di vita, e fuori da un ridisegno dei modelli di
coesione fra le generazioni e degli assetti del welfare, connessi alla mutata composizione della
popolazione.
Eppure, solo il 55% dei cinquantenni occupati (50% dei maschi e 62% delle femmine) si
dichiara contrario alla proposta di prolungare l’età lavorativa per legge; e tale risultato
riflette in prevalenza il giudizio espresso da operai e operaie con bassa scolarità , poiché fra le
altre categorie professionali la percentuale dei contrari si abbassa (dal 63% degli operai al 54%
degli impiegati ed insegnanti, al 40% dei lavoratori autonomi). Di più, ad una precisa domanda
su se stessi, il 59% degli occupati dice che intenderebbe lasciare il lavoro “non appena
possibile”, ma il restante 41% sarebbe intenzionato a rimanere al lavoro anche dopo aver
maturato i requisiti contributivi necessari per andare in pensione (ciò che il 20% degli
stessi occupati peraltro fa già ). E’ del tutto prevedibile che un’articolazione dei dati per settore e
dimensioni delle imprese potrebbe rendere il quadro più differenziato, ma vale sottolineare
come, nel complesso, una parte ampia degli occupati cinquantenni dica che rimarrebbe ancora
qualche anno al lavoro, anche se non ne fosse obbligata. Alla domanda sulle condizioni che
potrebbero favorire questa scelta, le più sottolineate sono: che il lavoro dia loro soddisfazione e
utilizzi al meglio le loro capacità , che ricevano una retribuzione adeguata operando in un
ambiente gradevole, che vengano rispettati dai più giovani, che siano facilitati da una maggiore
compatibilità degli orari con le altre loro responsabilità e impegni personali. Fra donne e uomini
emergono anche qui differente di accento, in particolare su alcune delle condizioni per
continuare: orari più compatibili sono definiti molto importanti dal 40% delle donne, rispetto al
21% degli uomini; l’esigenza di rispetto da parte dei giovani è molto sentita dal 41% delle donne,
rispetto al 27% degli uomini. Anche la qualità dell’ambiente di lavoro è sottolineata più dalle
donne, anche se vi annettono molta importanza anche gli uomini.
Se gli occupati non hanno molta fretta di andarsene, le stesse imprese presso le quali
lavorano o di cui hanno conoscenza indiretta non sono definite così ostili o inclini a
liberarsi della componente più matura del personale, come spesso si presume. Secondo il
66% degli intervistati, nei luoghi di lavoro “non si farebbe troppo caso all’età ” del dipendente, e
oltre il 70% concorda col giudizio secondo cui le imprese considererebbero gli ultra
cinquantenni come “persone d’esperienza su cui contare”, mentre il 58% condivide che “li
utilizzano come modello per insegnare il lavoro ai giovani”. Per confronto, circa il 40% ritiene
vero che “li considerano rigidi e superati”, mentre poco più del 30% conviene che “offrono
incentivi economici perché escano dal lavoro”.
Certo, il campione dei cinquantenni occupati nel 2006 non comprende quelli che hanno cessato
di esserlo prima. Né quelle situazioni di incertezza e di discontinuità che si sono venute
incuneando fra lavoro e pensione a seguito soprattutto dei processi di ristrutturazione dei
grandi gruppi industriali, che hanno allontanato quote importanti di lavoratori con più di 45
anni, lasciati da soli a fare conti gravosi fra un’età anagrafica troppo adulta per il mercato ed
un’anzianità contributiva troppo giovane per la pensione.
Probabilmente, il campione è esso
stesso un effetto di questi processi selettivi, a cui hanno concorso da un lato le “generose”
politiche di pre-pensionamento del recente passato e dall’altro le incertezze derivanti dalla
riforma delle pensioni, che hanno sospinto i più adulti e quelli meno attrezzati ai margini,
favorendo uno scoraggiamento che ne ha indebolito lo stesso processo di pensionamento. E’
quanto ci hanno ricordato nella fase di ricerca qualitativa alcuni colloqui con ex lavoratori e
lavoratrici pre-pensionati di un grande gruppo industriale: ti porti appresso un vissuto da
“esubero” che indebolisce ogni progettualità , mina la fiducia e rende difficile elaborare una
transizione verso nuove attività .
Però, sono quelli rappresentati dal campione i cinquantenni di adesso: quelli con cui dovrebbero
confrontarsi le proposte di riforma dei regimi pensionistici, ma ancor più le intenzioni e i
programmi che li guardano come protagonisti di processi di invecchiamento attivo diversi da
quelli toccati ai loro predecessori. Da questo punto di vista, l’immagine che essi offrono sembra
tutt’altro che chiusa e scoraggiante.
Ma, visti nella loro globalità nel campione rappresentativo di tutta la popolazione di 50-60 anni,
anche coloro che sono già in pensione risultano mediamente soddisfatti delle loro condizioni di
vita: dicono che sono fuori perché avevano raggiunto l’anzianità necessaria, e avevano voglia di
cambiare vita e coltivare altri interessi. Certo, in più di un caso su tre si sentivano anche
stanchi/stanche di lavorare (più che superati), e in uno su quattro non sopportavano più
soprattutto la fatica quotidiana degli spostamenti. In un numero di casi compreso fra il 15 e il
30% sono stati esplicitamente richiesti dall’azienda di dare le dimissioni o sono stati offerti loro
incentivi economici (soprattutto agli uomini), mentre in altri sono sopraggiunti problemi di
salute (20%, soprattutto fra le donne). Per il 30% circa hanno avuto un peso anche i timori di
perdere i diritti acquisiti a seguito delle sempre incombenti riforme pensionistiche.
Come per gli occupati, però, anche molti pensionati considerano senza preclusioni l’ipotesi
che loro stessi avrebbero potuto restare più a lungo al lavoro, soprattutto se avessero
potuto avere maggiori servizi di supporto per gli impegni di cura verso i loro familiari (genitori),
se avessero ricevuto una retribuzione più alta e se avessero goduto di una salute migliore (due
condizioni che ricevono all’incirca la stessa valutazione d’importanza), se avessero potuto
usufruire di orari più comodi e di condizioni di lavoro meno pesanti. Ma anche se fossero stati
più riconosciuti da dirigenti e colleghi, e se avessero potuto trasmettere le loro competenze ai
giovani. D’altra parte, anche ora il 30% circa dei pensionati affermano che gradirebbero avere
ancora un’occupazione retribuita.
Da quando sono in pensione, dicono di essere coinvolti in diverse attività , fra le quali però
quelle retribuite vengono dichiarate solo nel 6% dei casi. Fra le attività dichiarate più di
frequente spiccano quelle legate alla cura verso i familiari, cui si dedicano il 36% dei maschi e il
60% delle femmine. Seguono poi le attività sportive (25% dei maschi e 19% delle femmine),
quelle culturali e quelle ricreative (valori intorno al 15%, con poche e alterne differenze di
genere). Le attività di volontariato organizzate riguardano anch’esse una quota pari al 15% del
totale, mentre le attività di aiuto rivolte a vicini, conoscenti e simili riguardano un altro 7% circa
sia degli uomini sia delle donne.
In sostanza, sia dagli occupati sia dai pensionati cinquantenni emerge un’immagine
certamente composita, ma caratterizzata in grande prevalenza da soggetti ancora
solidamente inseriti tanto nella sfera esterna dell’occupazione e delle attività , quanto
nella sfera privata delle relazioni familiari e personali: sono adulti in senso pieno e
maturo, non anziani.
Quelli più soddisfatti delle loro condizioni di vita contano sulle loro esperienze, sull’autonomia
guadagnata e consolidata, sulle risorse che generose stagioni hanno prodotto in termini di
maggiore scolarità , buone condizioni di salute e capacità di curarsi, tutela sociale. Ma anche sulle
reti efficaci della solidarietà familiare che hanno consentito a donne e a uomini di crescere,
spesso partendo da situazioni modeste e difficili, e di affacciarsi ora abbastanza fiduciosi ai
molteplici passaggi di ruolo della loro età .
*****
Riferimenti
ABBURRÃ L., MIGLIORE M.C., (2004), Le sfide della popolazione all’economia e alla politica. Scenari sociali
e demografici per il Piemonte: alternative possibili e condizioni necessarie, IresScenari, 2004/4.
ABBURRà L., DONATI E., (2004), Ageing. Verso un mondo più maturo. Il mutamento delle età come fattore
di innovazione sociale, Quaderni di ricerca IRES Piemonte, n. 104.
ABBURRà L., DONATI E., (2007) I nuovi cinquantenni fra occupazione e attività . Transizioni nel corso della
vita adulta: comportamenti individuali e gestioni aziendali, Quaderni di ricerca IRES Piemonte,
n. 114.
AA.VV. “Il mutamento delle età ”, monografia pubblicata in InformaIres n. 1, marzo 2006.
Tutti i contributi sono reperibili sul sito www.ires.piemonte.it, nella sezione “pubblicazioni”.
|
|
|
 |
|
|
 |
|
I commenti degli utenti (Solo gli iscritti possono inserire commenti)
|
 |
|
|
|
|
 |
|
